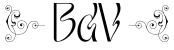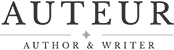Una maglietta rosa pastello, delicata. Non credo di aver mai più messo quella sfumatura dopo quel giorno. Ma non era il colore da bambina che mi piaceva, era l’iconico bat-segnale, quel pipistrello nero con le ali aperte: è l’unico ricordo che ho della prima manifestazione della mia vita.
Io sono la figlia di Batman.
Solo che invece di essere un facoltoso e stravagante miliardario falla mascella forte e dalla sessualità ambigua, Batman è un professore coi capelli neri e ormai radi che viaggia con la Gilera.
È il mio babbo, che si batte meglio di qualsiasi supereroe per difendere il suo posto di lavoro, ma soprattutto per difendere il diritto alla cultura di tutti coloro che hanno dovuto lasciare gli studi troppo presto. Mio padre lotta per i suoi studenti, che dalle 19 alle 24 imparano con lui nel fabbricato freddo e pieno di amianto accanto al Terzolle. Sono queste creature notturne il popolo dei Corsi Serali Comunali, il proletariato dell’istruzione.
C’è Giuseppe, che è entrato presto in Pignone, perché doveva aiutare la famiglia quando suo padre si è ammalato. C’è Sara, che dopo un’adolescenza raminga tra eroina, povertà e relazioni sbagliate vuole diventare assistente sociale. C’è Lorenzo, che ha preferito fare il magazziniere, perché in terza media lo hanno bocciato due volte: gliel’hanno sempre detto, che non era fatto per lo studio. Solo che dopo l’ennesimo turno con la sciatica, il ginocchio sinistro gonfio e le mani indolenzite come quelle di un novantenne, si è stancato di scaricare bancali. Ai corsi serali ha imparato che Dante o l’Eneide, alla fine, non sono rompicapo per ricchi oziosi con gli occhiali e donne della Firenze bene con la camicia di seta dalle spalline larghe e la collana di perle.
Brutus manda il bus e il suo lavoro gli piace anche: è massacrante, ma stare alla guida gli permette di osservare le persone. Però quel diploma lo vuole, perché magari un domani sarà stanco dei turni pesanti e vorrà cambiar lavoro. E poi è una sfida e lui alle sfide ci sta sempre: non per nulla il campo da basket gli è sempre piaciuto più del banco di scuola.
Non tutte le loro storie sono esemplari, da “Libro cuore”: la maggior parte sono personaggi che trovano il posto nelle ballate di Fabrizio de Andrè che sono solita canticchiare, ma il cui significato capirò solo crescendo.
A tutta questa umanità, fatta di gente che si spacca la schiena di giorno e poi la sera, di sua spontanea volontà, corre sui banchi di scuola per imparare in poco tempo quello che non ha potuto imparare nei cinque anni delle superiori, vogliono togliere gli insegnanti e i libri. Sia mai che il figlio dell’operaio possa diventare dottore per davvero. E poi tanto che cosa se ne fanno, queste vite da macello, della matematica o della filosofia? A cosa serve Cicerone o conoscere la Resistenza?
Fra quelle persone ci sono cresciuta, alcune sono diventate parte della mia famiglia. Vladimiro, un macchinista dall’apparenza rissosa e nerboruta, è uno zio dolcissimo che consuma più libri che bistecche e che si è innamorato della filosofia. Anche lui ha studiato ai Corsi Serali e si è diplomato col massimo dei voti.
Non è un caso che il bat-segnale lo vede forte anche lui, che è il migliore amico del mio babbo. E infatti alla manifestazione viene anche lui, ha cambiato il turno per l’occasione. Sono Superman e Batman, loro due, ma con la bandiera rossa: combattono insieme contro quel Joker dell’assessore che vuole chiudere la scuola.
Io mi preparo: i capelli lunghi e lisci raccolti in una coda, quella maglietta rosa sul corpo paffuto e goffo, le scarpine da ginnastica ai piedi. Se dovessi scegliere un’eroina, vorrei essere Lady Oscar: io i malvagi e i prepotenti li combatto a fil di spada.
Sono eccitata, ma ho anche un po’ di paura: nei fumetti e nei cartoni durante le battaglie qualcuno si fa sempre un po’ male e a me non è che piaccia tanto. C’è modo di prendersi a botte, ma al massimo medicarsi con un cerotto? Però dall’altra parte lo so bene, anche se sono solo una bimba, che le cose giuste e importanti non crescono sugli alberi, che Babbo Natale e la Fata Turchina sono due belle invenzioni, ma che alla fine tutto ciò che abbiamo di bello è perché il brutto lo abbiamo ricacciato in un angolo buio. E che se il pane lo lasci lì sulla tavola o si secca o ci vanno le formiche e poi non è più buono nemmeno per il cane. E che le rose e i fiori vanno difesi dai pidocchi e dalle erbacce se li vuoi vedere anche l’anno dopo.
E poi a me piace giocare coi supereroi. E penso che un giorno, da grande, voglio fare la supereroina anche io e lottare per il pane e anche per le rose. Il pane non è che mi garbi tanto, ma penso che la pastasciutta vada bene uguale, magari un gelato ogni tanto, tanto quello piace a tutti. E se invece di rose sono margherite o violette, come quelle che ci sono a casa della nonna in campagna, fa uguale.
E poi voglio esserci per il mio babbo e per i suoi amici-studenti. È vero, a volte mi dispiace quando mio padre se ne va via il pomeriggio e non lo vedo più fino alla mattina dopo, quando mi accompagna all’asilo. Però mio padre è Batman: lo sanno tutti che Batman lavora la notte! E non ce ne sono tante in giro, di figlie del Cavaliere della Notte.
Voglio andare perché mio babbo quando non lavora mi sembra sempre un po’ triste, perché lui lo sa che fa un mestiere importante, ma soprattutto perché è un mestiere che gli piace. E infatti lavoro anche quando sta a casa, si rinchiude nello studio con l’odore di tabacco della pipa.
Legge. Scrive. Pensa.
Io ci voglio andare, anche se la mamma dice che forse sono troppo piccina, che non è il caso, che ci sono cose che non devo sentire. Io a una manifestazione non ci sono mai stata. Però ne vedo sempre una in televisione il sabato mattina col mio babbo, seduti stretti sul divano, quando Jack ed Elwood aiutano le brave persone a buttare nel fiume i nazisti dell’Illinois. E allora immagino me e mio padre che voliamo con la motocicletta a sconfiggere quei nazisti che vogliono chiudere la scuola, perché anche io li odio, i nazisti dell’Illinois.
Alla fine, scendiamo davvero in piazza, anche se a piedi. Mio padre mi tiene per mano, ma io in mezzo a tutte quelle magliette dai colori sgargianti col pipistrello nero mi sento a casa. Del resto, tutti conoscono mio padre e di conseguenza anche me. Mi sento un po’ la mascotte, la nanetta magica del corteo dei Corsi Serali Comunali. La manifestazione è colorata, festosa, non mi fa per nulla paura. Sarà che è una bella giornata inondata di luce e di quel caldo afoso che ogni estate avvolge la Piana.
Imparo tante cose quel giorno, che mi porterò dietro per sempre. Che le lotte possono essere forti senza essere violente. Che l’unione fa la forza. Che il lavoro non è solo un modo per campare, ma è soprattutto dignità. Che ci vuole il pane, certo, ma ci vogliono anche le rose.
Quella volta la battaglia l’hanno vinta i buoni, ma non è mai come nei fumetti, non ci sono medaglie, riconoscimenti e lieti fini patinati. La società è cambiata, l’istruzione è cambiata, gli adulti che non hanno studiato parlano sempre meno italiano e sempre più le lingue del mondo. Mio babbo ha finito la carriera da un’altra parte, ma sempre combattendo contro i cattivi e le ingiustizie.
Per anni non ho più pensato a quella maglietta col bat-segnale, ma forse è vero che il Dna dei supereroi passa un po’ anche ai loro figli.
A me quel grido contro le ingiustizie ha continuato a risuonare dentro a ogni manifestazione: quando con mio padre gridavamo contro l’abolizione dell’articolo 18, che, da appena liceale, mi sembrava un miraggio tanto lontano. Quando sono scesa in piazza coi miei amici, l’anno dopo il disastro di Genova, a combattere col corpo contro quei pochi che impoveriscono la Terra e governano lo sfruttamento dei lavoratori e delle lavoratrici di tutto il mondo.
Poi a lavorare ci sono andata io, all’estero, a inseguire la promessa di poter far ricerca su frammenti dello scibile in arcani manoscritti minori di polverose biblioteche. Avevo trovato una nuova etichetta altisonante : “lavoratrice precaria della conoscenza”. Una bestia mitica, un po’ come l’unicorno: troppo colta e ricca (anche se i soldi non erano i miei!) per far parte del proletariato, “migrante d’oro”, “bambocciona” in cerca di un futuro migliore a Londra, ma comunque troppo povera e troppo precaria per far parte della borghesia.
Studiare, lavorare, sentirsi comunque sempre non all’altezza: “Sei molto competente, ma…”. Ma sei donna, ma sei straniera, ma set troppo qualificata… E quindi gli incarichi migliori e il posto fisso non sono alla tua portata, accontentati delle briciole, datti da fare di più. Mettiti a far lavori che ti mangiano il cuore dentro: in segreteria, a prendere appunti per studenti ricchi per davvero, a servire durante le conferenze nella speranza che qualche professore riconosca almeno la tua esistenza, a fare da campione per esperimenti… Di tutto per la soddisfazione di avere almeno due spiccioli in tasca e non sentirti inutile e divorata dai sensi di colpa anche solo per l’aria che respiri.
Perché la precarietà ti corrode, non importa che lavoro tu faccia o desideri di fare. È un acido che ti si insinua tra i tessuti, non ti fa dormire la notte, ti toglie pure la voce per reclamare i tuoi diritti. Di precarietà si muore: il pane manca, le rose sono appassite.
Io, poi, in Italia ci sono ritornata. Per viltà, per fallimento, perché mi sembrava che insegnare all’università per tre spicci a gente che delle mie parole aveva poco bisogno fosse inutile. Che l’orizzonte di senso non fosse solo il pane, ma anche le rose. E le rose di Regent’s Park fioriscono solo per chi riesce almeno a guadagnare 40.000 sterline l’anno.
Ho ricominciato a fare la precaria, ma a casa mia. A entrare in quel magico mondo che è l’istruzione, perché quello che so e quello che sono serva anche ad altri. Mi si apre un universo fatto di micro-contratti, di pezzi di carta che non bastano mai, di condizioni che cambiano a ogni rimpasto di governo, di diritti che non esistono. Ma capisco anche che ho trovato la mia rosa rossa, che non mi voglio più accontentare. Che voglio fare l’insegnante perché mi piace, perché mi sembra utile, perché così posso aprire un mondo di possibilità anche agli altri e fare loro amare ciò che amo io. O almeno provarci. E che non mi devo sentire in colpa, perché trovare soddisfazione nel proprio lavoro non dovrebbe essere un privilegio. Non siamo noi a essere viziati, è la società a sbagliare nel farti credere che devi sempre essere grato delle briciole. Io lo so, perché me lo ha insegnato il mio babbo. E i babbi, si sa, non mentono mai e se ti dicono di seguire il bat-segnale, il consiglio è giusto.
Che poi privilegiata no, ma fortunata lo sono. Perché io di rose sono riuscita a coltivarmene un cespuglietto. Sono rosse, sono piccole, hanno le spine acute e a volte anche gli afidi. Però alla fine della primavera fioriscono sempre. La precarietà, per me, è finita abbastanza presto.
Chissà, allora, perché della maglietta rosa con il simbolo di Batman mi sono ricordata proprio adesso. Sarà mica perché, appeso alla chiave del mio armadietto della sala insegnanti del mio liceo, ho un portachiavi a forma di pipistrello che si illumina?